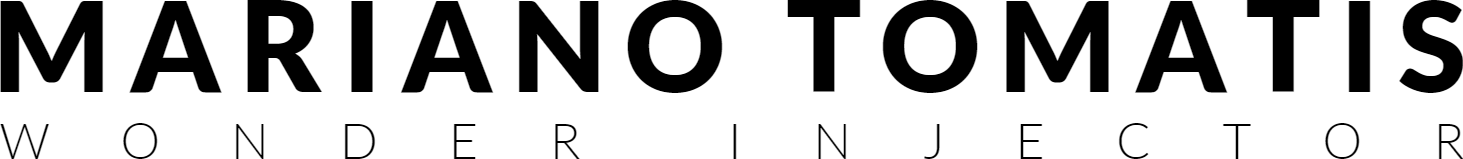William Gibson
Il continuum di Gernsback
Per fortuna gli effetti stanno svanendo, la faccenda si sta rivelando un episodio temporaneo. Quando ancora mi capita di vedere qualcosa, è ai margini del campo visivo: frammenti di assurde macchine cromate, appena intraviste. Ho visto un’ala volante sopra San Francisco, la settimana scorsa, ma era quasi trasparente. E le auto con le pinne di squalo si sono fatte più rare, le autostrade evitano discretamente di espandersi in mostri scintillanti a 80 corsie, come quello in cui sono stato costretto a guidare la settimana scorsa con la mia Toyota a nolo. E so che niente di tutto ciò mi seguirà fino a New York, il mio campo visivo si sta restringendo a una sola lunghezza d’onda probabilistica. Ho lavorato duro per ottenere questo risultato. La televisione mi è stata di grande aiuto.
Credo che sia cominciato a Londra, in quella taverna greca fasulla in Battersea Park Road, dove abbiamo pranzato a spese della ditta di Cohen. Tutta roba da tavola calda, e ci hanno messo mezz'ora per trovare un secchiello del ghiaccio per il vino. Cohen lavora per la Barris-Watford, che pubblica grandi libri illustrati molto chic sull’arte “commerciale”: la storia delle insegne al neon, i flipper, i giocattoli a molla del Giappone occupato. Ero andato in Inghilterra per una serie di fotografie pubblicitarie; ragazze californiane con le gambe abbronzate e scarpe da ginnastica dai vivaci colori fluorescenti che saltellavano in mio onore lungo le scale mobili di St. John's Wood e sui marciapiedi di Tooting Bec. Un giovane funzionario, magro e ambizioso, aveva deciso che i misteri della metropolitana di Londra sarebbero serviti a vendere scarpe di nylon con la suola da montagna. Loro decidono, io fotografo. E Cohen, che conoscevo vagamente dai tempi di New York, mi aveva invitato a pranzo il giorno prima della partenza da Heathrow. Era accompagnato da una signorina vestita molto alla moda, di nome Dialta Downes, una tipa praticamente senza mento, nota studiosa di storia dell’arte pop. Se
ci ripenso la vedo camminare a fianco di Cohen sotto un’insegna lampeggiante al neon, con scritto DIREZIONE: FOLLIA in grosse maiuscole senza terminazioni.
Cohen ci presentò e spiegò che Dialta era l’artefice dell’ultimo progetto della Barris-Watford, una storia illustrata di quello che lei chiamava “Stile Modernista Aerodinamico Americano”. Cohen lo chiamava “gotico spaziale”. Il titolo provvisorio era Futuropolis: La città mai esistita.
Gli inglesi hanno una tipica ossessione per gli aspetti più barocchi della cultura pop americana, qualcosa di simile al feticismo dei tedeschi occidentali verso gli indiani e i cowboy o all’assurda idolatria dei francesi per i vecchi film di Jerry Lewis. In Dialta Downes questo si manifestava in una mania per una forma di architettura squisitamente americana, ma di cui gli americani sono scarsamente consapevoli. All’inizio non ero ben sicuro di cosa stesse parlando, ma un po’ alla volta cominciai a capire. Tornai con la mente ai programmi televisivi della domenica mattina, negli anni ’50.
Qualche volta, sulla stazione locale, trasmettevano vecchi cinegiornali, come riempitivo. E mentre si stava seduti con un panino al burro di arachidi e un bicchiere di latte, una voce baritonale, hollywoodiana e gracchiante, raccontava che c’era “Una Macchina Volante nel Vostro Futuro”. E tre ingegneri di Detroit si davano da fare su una vecchia, gigantesca Nash alata, che si lanciava poi rumorosamente lungo qualche pista deserta del Michigan. Non la si vedeva mai decollare veramente, ma volava verso la terra inesistente di Dialta Downes, la vera patria di una generazione di tecnofili privi di inibizioni. Quello di cui mi stava parlando erano quei pezzi di architettura “futuristica” degli anni 20 e 30 che si incontrano ogni giorno nelle città americane senza accorgersene: le pensiline dei cinema con nervature che irradiano una misteriosa energia, i negozi con la facciata di alluminio scanalato, le sedie di tubo cromato che raccolgono la polvere negli androni degli alberghi di terza categoria. Lei vedeva queste cose come segmenti isolati di un mondo di sogno abbandonati in un presente indifferente; voleva che li fotografassi per lei.
Gli anni 30 avevano visto nascere la prima generazione di progettisti industriali americani. Fino agli anni 30 tutti i temperamatite sembravano temperamatite: il classico meccanismo vittoriano, al massimo un’ombra di decorazione. Dopo l’avvento dei designer, c'erano temperamatite che sembravano progettati nelle gallerie a vento. Nella maggior parte dei casi il cambiamento era solo superficiale; sotto il guscio cromato e aereodinamico c’era sempre il vecchio meccanismo vittoriano. Il che aveva una sua logica, perché i designer più abili erano usciti dalle file degli scenografi di Broadway. Era tutto un palcoscenico, una serie di fondali complicati per giocare a vivere nel futuro.
Mentre bevevamo il caffè, Cohen tirò fuori una grossa cartelletta piena di foto. C'erano le statue alate che facevano la guardia alla diga di Hoover, come decorazioni di cemento alte 12 metri soffiate da un immaginario uragano. C'erano una dozzina di foto del Johnsons Wax Building di Frank Lloyd Wright, affiancate alle copertine della vecchia Amazing Stories, dipinte da un tale di nome Frank R. Paul; probabilmente i dipendenti della Johnson's Wax avevano avuto l’impressione di entrare in una delle utopie aerografate da rivista popolare di Paul. L'edificio di Wright sembrava progettato per gente che indossava tuniche bianche e sandali di perspex. Mi soffermai sul disegno di un aereo a elica particolarmente maestoso, tutto ali, come un grosso boomerang simmetrico dotato di finestrini nei posti più inverosimili. Delle frecce indicavano la posizione della sala da ballo e di due campi da squash. Era datato 1936.
— Non mi direte che questa roba volava. — Guardai Dialta Downes.
— Oh, no, impossibile, anche con quelle 12 eliche giganti; ma alla gente piaceva quel look, capite? Da New York a Londra in meno di due giorni, sale da pranzo di prima classe, cabine private, ponti per abbronzarsi, serate danzanti con orchestra jazz... I progettisti cercavano di dare al pubblico quello che desiderava. E quello che il pubblico desiderava era il futuro.
Ero a Burbank da tre giorni impegnato a cercare di soffondere di carisma un cantante rock molto insipido, quando ricevetti il pacco di Cohen. È possibile fotografare l’inesistente, ma è maledettamente difficile riuscirci, e di conseguenza questo è un talento molto ricercato sul mercato. Anche se ci so fare, non si può dire che sia il migliore, e quel tipo metteva a dura prova la credibilità della mia Nikon. Uscii depresso perché mi piace fare un buon lavoro, ma non del tutto, perché mi ero assicurato di ricevere comunque l’assegno, e decisi di tirarmi su con la sublime artisticità del lavoro per la Barris-Watford. Cohen mi aveva mandato alcuni libri sul design degli anni ’30, foto di edifici aerodinamici, e una lista dei 50 esempi più importanti in California compilata da Dialta Downes.
La fotografia architettonica può comportare lunghe attese; l’edificio diventa una specie di meridiana, mentre si aspetta che l'ombra si allontani da un particolare, che la massa e l’equilibrio della struttura si rivelino in una certa maniera. Mentre aspettavo, mi immaginai nell'America di Dialta Downes. Quando isolavo alcuni edifici industriali nel mirino smerigliato della Hasselblad, questi assumevano una specie di totalitaria dignità, come gli stadi che Albert Speer aveva costruito per Hitler. Ma il resto era implacabilmente volgare: roba effimera, secreta dall’inconscio collettivo americano degli anni ’30, che sopravviveva lungo strade deprimenti su cui si allineavano motel polverosi, venditori all'ingrosso di materassi ed esposizioni di macchine usate. Mi buttai sulle stazioni di servizio.
Al culmine dell’Era di Downes, Ming lo Spietato era stato incaricato di progettare le stazioni di servizio della California. Seguendo l’architettura della sua nativa Mongo, aveva percorso in lungo e in largo la costa erigendo postazioni di cannoni laser in stucco bianco. Nella maggior parte vi erano superflue torrette centrali circondate da quegli strani radiatori che erano il marchio distintivo dello stile e sembravano generare potenti flussi di entusiasmo per la tecnologia. Bastava trovare il modo per riportarle in vita. Ne fotografai una, a San José, un’ora prima che arrivassero i bulldozer e distruggessero la verità architettonica di stucco, incannicciato e cemento da poco prezzo.
- Dovete immaginare - gli aveva detto Dialta Downes, - una specie di America alternativa: un 1980 mai esistito. Un’architettura di sogni infranti.
E quella era la mia disposizione mentale mentre percorrevo le stazioni della sua involuta via crucis socioarchitettonica nella mia Toyota rossa, e gradualmente mi sintonizzavo sulla sua immagine umbratile di un’America che non c’era, di fabbriche di Coca-Cola simili a sottomarini arenati, di cinema di quinta visione simili a templi di una setta perduta che aveva adorato specchi azzurri e la geometria. E mentre mi muovevo fra quelle rovine segrete mi trovai a pensare a cosa avrebbero pensato gli abitanti del futuro perduto del mondo in cui io vivevo. Gli anni ‘30 sognavano marmi bianchi e cromature aerodinamiche, cristalli immortali e bronzo brunito; ma i razzi sulla copertina delle riviste di Gernsback erano caduti su Londra in piena notte, sibilando. Dopo la guerra tutti avevano avuto una macchina, ma senza ali, e le autostrade promesse per farla correre, tanto che il cielo stesso si era oscurato e i fumi avevano divorato i marmi e corroso i cristalli miracolosi...
E un giorno, alla periferia di Bolinas, mentre mi stavo preparando a fotografare un esemplare particolarmente sontuoso di architettura militare Ming, penetrai una sottile membrana, una membrana probabilistica...
Senza accorgermene, superai il Confine...
E alzando gli occhi vidi un apparecchio a 12 motori, simile a un boomerang ingrossato, tutto ali, che si muoveva verso est con grazia elefantina, così basso che avrei potuto contarne i rivetti sullo scafo argento opaco, e sentire, forse, l’eco di un’orchestra jazz.
Andai da Kihn. Merv Kihn, giornalista indipendente specializzato in pterodattili texani, contadini reazionari che avevano avuto contatti con gli UFO, mostri di Loch Ness di terza classe e le dieci più diffuse teorie sulle cospirazioni nate nelle zone retrograde dell’immaginario collettivo americano.
— Non è male — disse Kihn, pulendosi gli occhiali da tiro a segno Polaroid con un lembo della camicia hawaiana — ma non è veramente cerebrale. Gli manca quel certo quid.
— Ma l’ho visto, Merv. — Eravamo seduti ai bordi di una piscina, sotto il sole splendente dell’Arizona. Lui era a Tucson, in attesa di un gruppo di impiegate statali di Las Vegas in pensione, la cui portavoce riceveva messaggi dagli Alieni per mezzo di un forno a microonde. Avevo guidato tutta notte, e me lo sentivo nelle ossa.
— Ma certo che l’hai visto. Hai letto i miei articoli; non hai ancora afferrato la mia soluzione definitiva del problema degli UFO? È semplicissimo: la gente — si sistemò accuratamente gli occhiali sul lungo naso aquilino e mi rivolse uno sguardo da basilisco — vede... delle cose. La gente le vede. Non c’è niente, ma la gente le vede lo stesso, capisci? Perché ne hanno bisogno, probabilmente. Hai letto Jung, dovresti sapere qual è la causa... Nel tuo caso è piuttosto ovvia: hai detto che stavi pensando a questa architettura demenziale, ci fantasticavi sopra... Ascolta, sono sicuro che anche tu ti sei fatto la tua parte di droghe, giusto? Quanti hanno visto passare gli anni Sessanta in California senza avere almeno una volta quelle strane allucinazioni? Per esempio quando sembrava che i jeans erano diventati un ologramma di geroglifici disegnati dalla Walt Disney, o quando...
— Ma non era così.
— Certo che non era così. Era completamente diverso. Era “su uno sfondo perfettamente reale”, giusto? Tutto normale, poi compare il mostro, il mandala, il sigaro fluorescente. Nel tuo caso un gigantesco aeroplano stile Amazing. Succede in continuazione. Non sei neppure pazzo. Lo sai, vero? — prese una birra dalla borsa refrigerante malandata che aveva vicino alla sedia a sdraio.
— La settimana scorsa ero in Virginia. Grayson County. Ho intervistato una ragazzina di 16 anni che era stata assalita da una testa di orso.
— Che?
— La testa tagliata di un orso. Se ne svolazzava in giro sul suo disco volante, che sembrava il coprimozzo della vecchia Cadillac di suo cugino Wayne. Aveva occhi rossi, luccicanti come due mozziconi di sigaro e antenne telescopiche che gli uscivano da dietro le orecchie. — Fece un rutto.
— E l’ha assalita? Come?
— È meglio che non te lo dica.
Sei un tipo impressionabile. “Era freddo” — fece una brutta imitazione dell’accento del sud — “e metallico.” Faceva suoni elettronici. È un prodotto genuino, amico: direttamente dall’inconscio collettivo; quella ragazzina è una strega. Non c’è posto per lei in questa società. Sicuramente se non fosse cresciuta con “L'uomo bionico” e le repliche di Star Trek avrebbe detto di aver visto il diavolo. Ha semplicemente seguito la corrente. E sa esattamente cosa le è successo. Ero uscito da dieci minuti quando sono arrivati gli ufologi con la macchina della verità.
Dovevo avere un’aria preoccupata, perché lui appoggiò la birra vicino alla borsa refrigerante e si alzò.
— Se vuoi una spiegazione più intellettuale, direi che hai visto un fantasma semiotico. Tutte queste storie di incontri ravvicinati, per esempio, sono calate nella dimensione fantascientifica che permea la nostra cultura. Posso anche credere agli alieni, ma non a degli alieni che assomigliano a fumetti degli anni ’50. Sono fantasmi semiotici, frammenti di un immaginario culturale che si è separato e ha acquistato una vita autonoma, come le navi volanti alla Giulio Verne che vedevano sempre quei vecchi contadini del Kansas. Tu hai visto un tipo diverso di fantasma, ecco tutto. Un tempo quell’aereo faceva parte dell’inconscio collettivo. In qualche maniera l'hai catturato. L'importante è non preoccuparsene.
Ma io me ne preoccupavo. Kihn si pettinò i radi capelli biondi e uscì per sentire cosa dicevano gli alieni sulle frequenze radar, e io tirai le tende della mia camera e mi stesi nel buio ad aria condizionata per preoccuparmi.
Stavo ancora preoccupandomi quando mi svegliai. Kihn aveva lasciato un biglietto sulla mia porta; aveva preso un volo charter diretto a nord, per controllare delle voci su mutazioni del bestiame. Un’altra delle sue specialità giornalistiche.
Io pranzai, feci una doccia, ingoiai una pillola dimagrante mezza sbriciolata che girava in fondo alla mia borsa da barba da tre anni, e ripartii per Los Angeles.
Le velocità mi limitava il campo visivo al tunnel creato dai fari della Toyota. Mi dissi che il corpo poteva guidare mentre la mente riposava. Riposava e si teneva lontana dalle bizzarre immagini prodotte dall’anfetamina e dalla stanchezza, la spettrale, luminosa vegetazione che cresce alla coda dell'occhio della mente, lungo un’autostrada a tarda notte. Ma la mente ha le sue idee, e l’opinione di Kihn su quello che ormai consideravo il mio “avvistamento” mi girava per la testa in un'orbita asimmetrica. Fantasmi semiotici.
Frammenti del Sogno Collettivo, che svolazzavano nella scia della macchina. Probabilmente tutto quel ragionamento fece uno strano effetto alla pillola dietetica, e la vegetazione confusa ai margini della strada assunse il colore delle immagini all’infrarosso dei satelliti, frammenti luminosi soffiati via dalla Toyota.
Allora parcheggiai, e il riflesso dei fari sulle lattine di birra sparse in strada cessò improvvisamente quando spensi i fari, come un augurio di buona notte. Calcolai che ore dovevano essere a Londra, e cercai di immaginarmi Dialta Downes che faceva colazione nel suo appartamento di Hampstead, circondata da statuette cromate e libri sulla cultura americana.
Le notti del deserto, là, sono enormi; la luna è più vicina. Osservai a lungo la luna e decisi che Kihn aveva ragione. L'importante era non preoccuparsi. In tutto il continente, gente più normale di quanto avrei mai potuto essere, vedeva ogni giorno uccelli giganti, yeti, raffinerie petrolifere volanti; servivano a dare lavoro a Kihn. Perché sentirsi sconvolti da una visione dell'immaginario popolare a passeggio nel cielo di Bolinas? Decisi di addormentarmi, avendo come unica preoccupazione i serpenti a sonagli e gli hippie cannibali, al sicuro fra l'amichevole spazzatura del mio continuum quotidiano. La mattina avrei raggiunto Nogales e fotografato i vecchi bordelli, una cosa che volevo fare da anni. La pillola dietetica aveva dato forfait.
Prima mi svegliò la luce, poi le voci.
La luce veniva dalle mie spalle e gettava ombre mutevoli nella macchina. Le voci erano calme, indistinte, maschili e femminili, e conversavano fra alieni.
Avevo il collo irrigidito, e mi sentivo gli occhi impastati. Mi si era addormentata una gamba, premuta contro il volante. Cercai gli occhiali nella tasca della camicia, e alla fine li trovai.
Poi mi guardai alle spalle e vidi la città.
I libri sul design degli anni ’30 erano nel portabagagli; in uno di essi c'erano delle illustrazioni di una città idealizzata, ricavata da Metropolis e dal Mondo futuro, ma in cui tutto era più squadrato e si innalzava attraverso perfette nuvole architettoniche, fino a pontili di attracco per dirigibili e assurdi pinnacoli fluorescenti.
Quella città era un modello in scala di quella che c’era alle mie spalle. Guglie si innalzavano su altre guglie, in scintillanti gradini da ziggurat che culminavano in un tempio dorato a forma di torre, con quelle pazzesche flange da radiatore delle stazioni di servizio Mongo. Nella più piccola di quelle torri avrebbe trovato posto l’intero Empire State Building. Strade di cristallo si snodavano fra i pinnacoli, e su di esse scorrevano forme lisce e argentee come perline di mercurio. L'aria era piena di navi: transatlantici tutti ali, piccoli oggetti argentei dardeggianti (qualche volta una delle gocce di mercurio si sollevava elegantemente dai pontili aerei e si univa alla danza), dirigibili lunghi un miglio, cose simili a libellule che erano girocotteri...
Chiusi forte gli occhi e mi girai sul sedile. “Quando li riapro” mi dissi “devo vedere il contachilometri, la polvere bianca della strada sul cruscotto di plastica nera, il portacenere pieno.”
— Psicosi da anfetamine — dissi. Aprii gli occhi. Il cruscotto c’era ancora, con la polvere e i mozziconi schiacciati. Adagio, senza muovere la testa, accesi i fari.
E li vidi.
Erano biondi. Erano in piedi vicino alla Alieni macchina, una pera di aliuminio, con una pinna da squalo che sporgeva dalla linea centrale e pneumatici neri e lisci come quelli di un giocattolo. Lui le teneva un braccio attorno alla vita e gesticolava verso la città. Indossavano fluenti vesti bianche che lasciavano scoperte le gambe, e sandali bianchi immacolati. Nessuno dei due sembrava essersi accorto dei miei fari. Lui stava dicendo qualcosa di saggio e importante, e lei annuiva, e d’improvviso io ebbi paura, paura in modo completamente diverso. L'equilibrio mentale aveva cessato di essere un problema; sapevo, in qualche maniera, che la città alle mie spalle era Tucson: una Tucson di sogno, creata dal desiderio collettivo di un’epoca. Sapevo che era reale, del tutto reale. Ma la coppia di fronte a me viveva lì, ed erano Alieni a spaventarmi.
Erano i figli degli “Anni 80 mai esistiti” di Dialta Downes; erano gli Eredi del Sogno. Erano bianchi, biondi, e probabilmente avevano occhi azzurri. Americani.
Dialta aveva detto che il futuro era arrivato prima in America, ma che poi se l’era lasciata alle spalle. Ma non qui, nel cuore del Sogno. Noi avevamo proseguito, in una logica onirica che ignorava l'inquinamento, i limiti dei combustibili fossili, le guerre che era possibile perdere. Erano felici e del tutto soddisfatti di loro stessi e del loro mondo. E, nel Sogno, quel mondo era loro.
Alle mie spalle, la città illuminata: riflettori fendevano gioiosi il cielo. Li immaginai radunati sulle piazze di bianco marmo, puliti e attenti, con gli occhi che brillavano di entusiasmo per i viali luminosi e le auto argentee. Avevano una sinistra vitalità da propaganda della Gioventù Hitleriana.
Avviai la macchina e avanzai adagio, finché il paraurti fu a un metro da loro. Ancora non mi avevano visto. Abbassai il finestrino e ascoltai quello che diceva l’uomo. Le sue parole erano limpide e secche come un dépliant della Camera di Commercio, e io sapevo che lui credeva senza riserve a quello che stava dicendo.
— John — sentii dire la donna — ci siamo dimenticati di prendere le pillole nutritive. — Tirò fuori due cialde da un oggetto che aveva alla cintura e ne passò una all’uomo. Io feci retromarcia fino all’autostrada e riparti verso Los Angeles, rabbrividendo e scuotendo la testa.
Telefonai a Kihn da una stazione di servizio. Gli dissi che era una storia nuova, di un brutto stile spagnolo moderno. Era appena tornato dalla sua spedizione, e non sembrava infastidito dalla mia chiamata.
— Sì, è una cosa bizzarra. Hai cercato di fare delle foto? Non vengono mai, ma aggiungono un tocco di mistero alla storia, il fatto che non si riesca a svilupparle...
Ma cosa dovevo fare?
— Guarda molta televisione, in particolare quiz e telenovelas. Vai a vedere film porno. Hai mai visto Nazi Love Motel? Lo trasmettono via cavo. E veramente mostruoso. Proprio quello che ti serve.
Ma di cosa stava parlando?
— Smettila di gridare e ascoltami. Ti svelerò un segreto del mestiere: i peggiori sottoprodotti dei media possono esorcizzare i fantasmi semiotici. Se con questo sistema sono riuscito a salvarmi dai marziani, allora dovrebbe andar bene anche per i tuoi incubi futuristi Art Deco. Cos'hai da perdere?
Poi si scusò, dicendo che aveva un appuntamento la mattina dopo con l’Eletta.
— Chi?
— La vecchia che parla con Vega, quella del forno a microonde.
Presi in considerazione la possibilità di chiamare Londra a carico destinatario, scovare Cohen alla Barris-Watford e dirgli che il suo fotografo era partito per una lunga vacanza nella Zona Oscura. Alla fine mi lasciai preparare da una macchina una tazza di caffè imbevibile e risalii sulla Toyota per l’ultima tirata fino a Los Angeles.
Scoprii che andare a Los Angeles era stata una pessima idea, e ci passai due settimane. Era tutto territorio di Downes; c’era troppo del Sogno, lì, troppi frammenti del Sogno pronti a catturarmi. Per poco non fracassai la macchina su un raccordo vicino a Disneyland, quando la strada si spalancò a ventaglio come un origami, e mi ritrovai a zigzagare fra una decina di corsie, in mezzo a centinaia di gocce cromate con pinne da Cadillac sul retrotreno. Peggio ancora: Hollywood era piena di gente che assomigliava troppo alla coppia che avevo visto in Arizona. Mi misi d’accordo con un regista italiano che sbarcava il lunario facendo lavori di sviluppo e stampa e installando pavimentazioni attorno alle piscine in attesa che arrivasse la sua grande occasione.
Lui mi stampò tutti i negativi che avevo accumulato per Downes. Io non volevo guardarle. Ma a Leonardo non facevano alcun effetto, e quando ebbe finito diedi un’occhiata alle stampe, sfogliandole come un mazzo di carte, le chiusi in busta e le spedii a Londra per posta aerea. Poi presi un taxi fino a un cinema dove davano Nazi Love Motel, e tenni gli occhi chiusi dall’inizio alla fine.
Il telegramma di congratulazioni di Cohen mi arrivò a San Francisco una settimana dopo. Dialta aveva apprezzato molto le foto.
Lui era rimasto colpito da come mi ero “immedesimato”, e sperava di lavorare ancora con me.
Quel pomeriggio vidi un’ala volante sopra Castro Street, ma aveva un aspetto diafano, come se ci fosse solo per metà. Corsi all’edicola più vicina e presi tutto quello che riuscii a trovare sulla crisi petrolifera e il rischio nucleare.
Avevo appena deciso di comprare un biglietto aereo per New York.
— In che razza di mondo viviamo, eh? — l’edicolante era un negro magro, con i denti cariati e un parrucchino quasi ostentato. Io annuii, frugandomi nelle tasche
dei jeans alla ricerca dei soldi, ansioso di trovare una panchina in un parco per immergermi nella prova lampante della quasi-distopia in cui vivevamo. — Ma potrebbe essere peggio, eh?
— Già — dissi io. — O peggio ancora, potrebbe essere perfetto.
Lui mi guardò mentre mi allontanavo stringendo sottobraccio il mio fagottino di catastrofi.
William Gibson, “The Gernsback Continuum” in Universe (“Burning Chrome”), N. 11 (di 17), Doubleday, New York 1981 è stato pubblicato in Italia con il titolo “Il continuum di Gernsback” su Urania, n. 1110, 24.9.1989 (“La notte che bruciammo Chrome”).